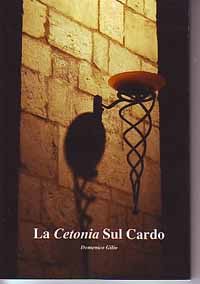 Domenico Gilio è poeta in continuo svolgimento. Non stupisce questa crescita speculativa, fusa, in modo osmotico, alla perizia tecnica, la quale, lungi dall’isterilire il battito lirico, lo rafforza, lo inquadra dentro certe realtà trasfigurate, ove non il simbolo, ma la lacerazione di ordine metafisico porta a risultati sorprendenti.
Domenico Gilio è poeta in continuo svolgimento. Non stupisce questa crescita speculativa, fusa, in modo osmotico, alla perizia tecnica, la quale, lungi dall’isterilire il battito lirico, lo rafforza, lo inquadra dentro certe realtà trasfigurate, ove non il simbolo, ma la lacerazione di ordine metafisico porta a risultati sorprendenti.
Ma procediamo con ordine.
“La cetonia sul cardo” è una silloge breve, di poche poesie. Intensa al punto da richiedere una lettura a pause, anche perché ogni lirica ha una sua strana autonomia espressiva, pure se, in fondo, l’intero tracciato forma una sorta di poemetto in cui si giocano tutte le carte della tensione emotiva e intellettuale dell’autore, il quale mostra ancora una volta – ancorché in modo più deciso ed autocosciente – una sensibilità delicatissima, eppure forte, tenera e decisa, sospesa sul dubbio fecondo e tuttavia sicura di un approdo.
“Mio Dio, con timore/ io scruto il tuo mistero. Fu il creato/ sei attimi di quiete”: però, dalla certezza della Creazione, che fa paura e incute ammirato silenzio per abbandonarsi al mistero, subentra il dubbio inappagato: “ Io ho conosciuto il male/ e il perché non comprendo”. Poi, con amara constatazione, che si fa quasi maledizione da cui l’uomo procede ab imo – in aeternum, nasce questa mirabile quartina, che è al tempo stesso imprecazione e preghiera ottativa: “Questo è il destino/ dell’uomo nel peccato, se ogni figlio/ può essere Caino a suo fratello;/ e ogni seme che nasce è in sé corrotto”.
Sono versi che lacerano, eppure contengono un palpito di assurda speranza, al limite, perché il poeta continua, con una formidabile intuizione: “Nell’universo, mia unica dimora,/ se mi perdo io, mi avrai perduto Tu”. E poi: “E mai lo sguardo tuo/ sarà pacificato”: è un ribaltamento teologico dell’essere transeunte al cospetto dell’Ente. L’uomo torna centro – sebbene doloroso – di quell’universo di cui ora è insignificante periferia.
Il testo data Natale 2007, quindi è molto recente. Questo ha il suo peso. Più si approfondisce la ricerca umana, più il perché finale ci viene sempre rimandato, a mò di boomerang, indietro dal muro del mistero. (In “Eva Genitrice” la lirica si fa preghiera; la nostra prima madre assume in sé significati escatologici e terreni fusi in un’umanità ch’è tipica del nostro Domenico Gilio: egli è un lirico che sboccia sempre, a nuovi risultati, dalveterotestamentarie: Eva è benedetta dal momento che ha rotto il primo incanto della nostra infanzia primigenia, beata nella gabbia d’oro dell’incoscienza: Eva ha creduto in se stessa e alle dolci lusinghe della vita. Non ha peccato. Sulle sue orme, anzi, ogni essere torna, “anima orante”. Il sogno di Eva è frutto unico d’amore.
E leggiamo questo supremo battito di trasfigurazione (nonché di nobile eresia, vivaddio!), in cui si capovolgono gli assunti e l’uomo prende atto di una nuova metamorfosi nel campo minato – ma sovrano – delle cose fondamentali, dei fini ultimi (che sono pure quelli degli inizi “ultimi”, cioè estremi e senza possibilità di risposta, se non il coraggio trasgressivo ed eroico del pensatore–poeta): Nel battesimo,/ figli d’ebbrezza, noi ci ricongiungiamo/ in un perpetuo patto/ di speranza e follia”. La preghiera alla nostra madre Eva continua: “Risparmia da ogni male/ solo la bianca infanzia e mai da impura/ mano sia lesa la sua leggerezza./ E meno grave sia/ ogni nostra vecchiezza”.
C’è un incanto di atmosfere in bilico pericolosissimo e in osmosi creativa fra il cosiddetto canto lirico e la speculazione coraggiosa, controcorrente, eroicamente blasfema per coloro i quali si addormentano, fuori del dubbio, nelle tristi certezze canoniche di chi ha stabilito una volta per tutte e per sempre un’unica giustificazione al male, un unico canone alla poliedrica contraddizione della vita. Questa poesia è il punto di “non ritorno” della sapienza scritturale di Domenico Gilio.
Procederemo, d’ora innanzi, con più rapido sguardo, estraendo dal contesto quei particolari ( e non sono pochi), che arricchiscono un quadro già ben delineato da questi due incipit tematici, contenenti in sé tutte le pur vibranti e straordinarie Variazioni”.
Dire però che esse esauriscono la silloge sarebbe limitativo ed ingiusto, dato che Gilio è – ripeto – un poeta in divenire, che lievita di generazione spontanea ( voglio indicare al lettore “ Strade di Acerenza”, che riprende, sotto altri aspetti, il tema del misterioso “seme” nato corrotto, sostituendolo con un “seme fecondo” che il vento della distruzione ha disperso: la vita è lì, in attesa, perché “non è impune l’andare”: essa “ ha in serbo un conto” che ognuno di noi dovrà saldare: un conto, e non un premio).
Le strade di Acerenza, il paese natio di Domenico Gilio, non sono più vive, perché è passata la fiabesca infanzia: “ sotto immemore crollo/ geme un mondo di fiabe,/ di dolci amplessi, di sussulti e corse/ delle infanzie fiorite. Nelle mani/ della Fortuna è il gioco.” Da qui, nella crescita che si ricollega alla scoperta del cosiddetto peccato ( di veterotestamentaria realtà: cfr. Eva), perduta l’innocenza della prima età della storia e della vita singola, “Sarà l’uomo/ pronto a incontrare Dio?” È martellante il ritornare del problema di Dio, punto cruciale su cui tutto ruota nella poetica di Gilio: ma non è preghiera, o meglio: non è preghiera canonica, in quanto l’uomo si pone sì sul piano della creatura di fronte al Creatore, ma non si svilisce né col senso del peccato né con quello dell’annullamento in Lui: “Se ti perdo io, mi avrai perduto Tu”, “Ma la cenere/ della sconfitta non distrugge il fuoco”, “Non c’è un’arca che salva”. Sono affermazioni dure, che danno il senso della forza di questa silloge, della sofferenza di essere uomo, perché all’altezza del dubbio e del dialogo con Dio. Sono sicuro che gli antologisti della “poesia religiosa” non accetteranno tale assunto. E peggio per loro! Se si tratta, infatti, di una posizione di colpa davanti al mistero della vita, Gilio risponde chiaro: “A diuturne fatiche uomini, in file/ di formiche, invadevano le strade,/ le membra ancora affrante./ Solo un breve tepore/ sui giacigli era sceso. Una stilla di quiete,/ a cancellare colpe inesistenti”. Si notino le rime interne, le assonanze, il taglio del verso che vuole essere ipermetro (14 sillabe, ad esempio), e invece insiste sul doppio ferecrateo, triplo anzi, per chiudere con l’endecasillabo maggiore piano.
E, tuttavia, quando si rilegge il testo, si ha voglia di mescolare le poesie come un mazzo di carte, per vedere che effetto fa una diversa posizione consequenziale. Se, puta caso, iniziassimo con “Nuova scienza”, e con la stessa chiudessimo il discorso, il complesso non ne risentirebbe, ma la stessa convinzione sarebbe indirizzata ( come lo è ormai la mia ), verso una più drammatica visione della vita, benché risolta nel dualismo “miele-veleni”, “dolore-allegria”, inevitabili forze contrarie dell’esistere. Se Pandora offre miele e veleno, il tempo copre “dolore ed allegria”, le quali sono forme umili di vita che, però, avvicinano a Dio.
Quando si incontrano versi di questa potenza ( “Il pensiero, disanimato vento”; “E Primavera immemore/ senza rondini torna”; “Non c’è un’arca che salva/ nell’assiduo momento che oltrepassa:/ tutto è un baleno in mezzo al temporale”; “E la preghiera/ reificato soffio/ su morte foglie cade”; “Fiori rossi di prati e di leggenda”; “Il rischio e la domanda/ inascoltata/ sul perché del tutto”,ecc.), versi-chiave, dai quali ripartire per una rilettura slegata dalla cifra “ordinale” data dall’autore, ne viene fuori una verifica, una sorta di cartina di tornasole.
E, allora, si scopre anche la innegabile “sapienza” metrica di Domenico Gilio, al quale nulla accade a caso. Oggi, infatti, bisogna stare molto attenti: è facile e sconfortante cadere nel tranello del semplice “andare a capo” nel “comporre cosiddetto libero”. Gilio elegge il settenario come propria cifra di raccordo sonoro fra endecasillabi per lo più maggiori ed accentati all’essenziale, ma gli accordi vengono scelti pure coi quinari, sebbene il flusso melodico incastri in ritmi che risultano più complessi il gioco degli intrecci sonori, i quali aderiscono sempre –ripeto: con sapienza – a un ritmo che altri definirebbero interiore, ma che io nomino “flusso biologico istintivo”, non scindibile dal sussurro verbale che ne è la sostanza stessa e non la forma o il vestito.
Prorompono nelle liriche passaggi ritmici di assoluta bellezza , in cui settenari e quaternari o quinari che iniziano con vocale, formano endecasillabi di perfetta fattura, che si rincorrono, inanellati tra di loro in un movimento a cascata, e formano spazi percettivi, come archi tesi di grande suggestione visiva e sonora, unici esempi nella nostra letteratura, classica o contemporanea. In Gilio quindi il ritmo nasce contemporaneamente con la stessa parola ed è tutt’uno col pensiero: da qui lo stile, irripetibile dell’Autore.
Goethe diceva che la natura non è corteccia e tronco, ma albero insieme. Da qui l’impossibilità di mutare una sola “acca” a quanto nasce definitivo ( varianti a parte: esse non fanno la storia: per questo gli amatori cercano sempre la prima stesura), perché l’acqua che sgorga alla sorgente non è più idrogeno e ossigeno. E’ un’altra cosa. Il buio dei tempi e i complessi meccanismi chimici hanno fatto il loro lavoro “a priori”. Tutto quanto accadrà dopo, alla luce del sole, sui balzi e nelle pianure, fino al mare, lo registra e lo conduce la mano dell’Artista, ma dentro di sé, nel buio della sua storia interiore, il processo ha operato da solo. Se così non fosse, con un pizzico di pazienza e un po’ di scaltrezza, conoscenza della sintassi e qualche scheggiamento di altri autori, tutti sarebbero poeti ( nel senso etimologico della parola).
Ma poiché così non è – per fortuna -, la poesia o è “a priori”, o non è.
La cifra di Gilio è autentica.
Aldo Onorati
